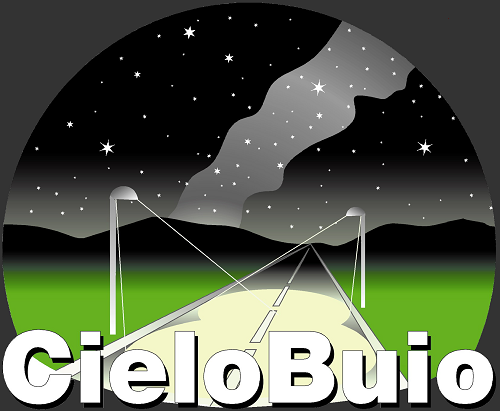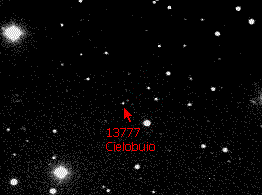la Repubblica – 22/07/2002
Breve digressione sul significato di “patrimonio dell’umanità”.
Chi avrebbe pensato che la notte fosse un bene a rischio, un’entità fragile bisognosa di protezione? Dalla notte, non più placida, dopo le lucciole pasoliniane stanno per scomparire anche le stelle? Che cosa ne direbbe Kant? Mentre a fatica continuiamo a cercare la legge morale dentro di noi, stiamo perdendo il cielo stellato sopra di noi? Queste domande non nascono da fantasie estive. Rispecchiano un documento approvato dall’Unione astronomica internazionale e da altre istituzioni di ricerca che chiedono all’Unesco e all’Onu “di avviare il procedimento per dichiarare il cielo notturno patrimonio dell’Umanità”. La ragione di questa richiesta e di questo allarme hanno la origine “nel cattivo uso e nella impropria diffusione dei sistemi di illuminazione, che tra l’altro comportano anche spreco energetico”, e che in zone sempre più vaste del mondo precludono la contemplazione delle stelle. Siamo dunque di fronte ad un nuovo caso di inquinamento, che si aggiunge a quelli già noti e che contribuisce ad alterare profondamente l’ambiente in cui viviamo. E la proposta è radicale: il cielo vga restituito all'”umanità”, torni ad essere, com’è nella sua natura, “patrimonio” di tutti. Un bene irrinunciabile. “Voila le firmament, le reste est procedure” – scriveva Paul Valéry.
Ma che cosa significa concretamente « patrimonio dell’umanità », perché si ricorre a questa formula? L’espressione non è nuova, viene da anni adoperata per designare beni che si vogliono sottrarre alla sovranità degli Stati e alla logica proprietaria del mercato. Non è poco, visto che l’associazione tra sovranità e proprietà ha costituito uno dei capisaldi dell’ordine politico e giuridico: liberi gli Stati di esercitare il loro diritto di conquista degli spazi non occupati, liberi i privati di muoversi a loro piacimento nell’utilizzazione dei beni a loro disposizione.
Proprio questa premessa è stata revocata in dubbio da una serie di trattati e dichiarazioni internazionali che hanno via via incluso nel patrimonio dell’umanità l’Antartide e il fondo del mare, la luna e i corpi celesti, la biodiversità e il genoma umano, complessi architettonici e ambienti naturali. Gli Stati non possono piantare la loro bandiera sull’Antartide o sulla Luna, non possono impunemente distruggere o alterare beni culturali e ambientali. I privati non possono invocare l’assolutezza dei diritti di proprietà e dichiararsi indifferenti di fronte agli effetti distruttivi delle loro attività economiche. Si vuole così segnare l’abbandono progressivo, e definitivo, della logica predatoria della conquista, sconfiggere l’egoismo statuale e proprietario in nome di interessi sopranazionali e collettivi, appunto l’interesse dell’umanità.
Si svela in questo modo un problema generale, e ormai ineludibile. Quali sono le materie che esigono una considerazione planetaria, e per le quali dev’essere quindi negata la competenza esclusiva degli Stati nazionali? Quali sono i beni la cui utilizzazione deve obbedire uniocamente a logiche non proprietarie?
Gli effetti della globalizzazione avevamo cominciato a conoscerli prima che questo termine entrasse nell’uso, quando si parlava della foresta amazzonica come elemento essenziale dell’ecosistema planetario; delle piogge acide che inquinano luoghi anche lontanissimi da quelli in cui hanno origini gli agenti nocivi; dell’inquinamento dei grandi fiumi che attraversano Stati diversi; della nuvola di Chernobyl; del buco dell’ozono, e via elencando. Saltavano vecchie paratie stagne, e con esse un rassicurante sistema di concetti politici e giuridici che chiudeva ciascuno nelle certezze affidate ai confini nazionali ed al potere esclusivo del proprietario. E le cronache di tutti i giorni ci ricordano che si tratta di un fenomeno che si espande, investe le materie più diverse, determina conflitti aspri.
Pochi giorni fa a Barcellona, ad esempio, durante la conferenza internazionale sull’Aids è tornata la questione dei farmaci, dove s’intrecciano sovranità e proprietà, dove si fa evidente il conflitto tra difesa della proprietà (il brevetto) e la tutela di un diritto fondamentale e universale come quello della salute. Si sa che la questione è nata perché i Paesi più poveri non sono in grado di sopportare i costi elevati dei farmaci per curare innanzitutto i milioni di malati di Aids. Così il Brasile ha cominciato a rompere il fronte, producendo i medicinali senza rispettare i brevetti di grandi case farmaceutiche. Anche il Sudafrica ha respinto la logica esclusiva del brevetto, le case farmaceutiche hanno reagito rivolgendosi alla Corte suprema di quel paese, ma alla fine hanno dovuto cedere. La logica non proprietaria della salute ha prevalso sulla logica proprietaria del brevetto.
Attenzione, però. Questo atteggiamento, che sembra indissolubilmente legato alla debolezza economica e ad una mancanza di rispetto per il dogm della proprietà, è improvvisamente comparso nela paese più ricco e più “proprietario” del mondo, gli Stati Uniti, quando l’amministrazione americana ha dovuto fronteggiare l’allarme determinato dall’invio di lettere contenente antrace. Visti i costi di massicci acquisti dei medicinali necessari, non ha accettato i loro prezzi di mercato ed ha “preteso”ai produttori un prezzo politico. Proprio quel tipo di prezzo che, per evitare polemiche ed allontanare più decisi attacchi al principio del brevetto, oggi molte case farmaceutiche dichiarano di essere pronte a praticare a favore dei paesi economicamente più deboli.
L’umanità, dunque, pretende che la salute non venga considerata come una merce, affidata alla sola logica del mercato, dive si compra tanta salute quanta ne consentono le disponibilità finanziarie. Un problema tutt’altro che teorico. Proprio in questi giorni si discute in Italia del ritorno al sistema delle mutue e, in Francia, il nuovo ministro della salute parla del sistema sanitario pubblico come di “una proprietà, di un bene comune, di tutti”.
Continuiamo ad usale le vecchie parole – patrimonio, proprietà – ma il loro significato mutua radicalmente quando esse vengono accompagnate dal termine “comune”. Non si riferiscono più all'”individualismo proprietario”, ad un potere di escludere gli altri e di usare un bene a proprio piacimento. Rimandano, invece, a valori collettivi, a legami e responsabilità sociali costruiti proprio attraverso il riferimento comune a determinati beni. Pongono così un continuo problema di selezione di interessi: quali possono essere affidati al mercato e quali debbono rimanerne fuori, in una dimensione sempre più larga e variegata. La grande promessa di Internet dev’essere interamente affidata al sistema delle imprese, o della rete dev’essere salvaguardata anche la natura di libero spazio di informazione e di confronto? Quali informazioni personali devono essere sottratte alle utilizzazioni commerciali? Le ricerche sul menoma umano possono essere intralciate da barriere monopolistiche? Si può ammettere un mercato del corpo, delle sue parti e dei suoi prodotti?
Questo diverso modo di riferirsi alla proprietà ed al patrimonio ci parla di indipendenza. Se, ad esempio, torniamo al caso mille volte citato dell’Amazzonia, si può chiedere ai soli paesi dove si trova la foresta di salvaguardarne la funzione preziosa nell’ecosistema mondiale, sopportando così tutti i costi di un’operazione resa necessaria nell’interesse comune dell’umanità? Se tutto il pianeta gode dei vantaggi della conservazione della foresta, è giusto che quei costi siano distribuiti tra i beneficiari, in una logica che non è più quella dell’indennizzo al proprietario espropriato, ma del contributo alla gestione di un patrimonio comune.
Ma chi parla a nome dell’umanità? Vi sono testi internazionali, come quelli sull’Antartide o sul fondo marino, che individuano soggetti e procedure delle decisioni. Il diffondersi dei riferimenti all’umanità, tuttavia, porta con sé un pericolo, divenuto evidentissimo quando si è trattato di tradurre in azioni concrete il “diritto d’ingerenza umanitaria”. Se tutti si sentono legittimati a parlare in nome dell’umanità, fuori d’ogni regola, non prevarrà la voce del più forte? Ecco, allora, la necessità di tradurre il riferimento forte all’umanità in regole altrettanto forti che disciplinino l’azione di soggetti democraticamente legittimati e controllabili, che possano parlare appunto a nome dell’umanità tutta.
Questo non è un risultato raggiungibile con un colpo solo, identificando un unico portavoce dell’umanità. Richiede una strategia articolata e una costruzione continua, che passa attraverso la piena attuazione dello statuto (e alcune riforme) dell’Onu, l’esecuzione di diverse convenzioni internazionali, l’operativtà di istituzioni come il Tribunale penale internazionale, al quale è stato affidato proprio il compito di perseguire i crimini contro l’umanità. Chi si estranea da questo processo, o lo intralcia o lo ritarda, rivela spirito di dominio, propensione per la legge del più forte e si assume responsabilità grandissime davanti all’umanità intera. E’ un atteggiamento autoritario, e miope: rifiutando queste forme di collaborazione, ci si presenta agli occhi del mondo nelle vesti dell’avversario, attirando su di sé ostilità e spiriti aggressivi, alimentando così quell’insicurezza che si dice di voler debellare.
Solo una grande “dichiarazione d’indipendenza” può promettere all’umanità un diverso futuro.
Stefano Rodotà